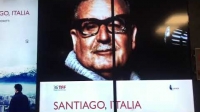Luigi Grande è nato a Palermo, ma è Genova la città dove è cresciuto, si è formato e che ha un posto speciale nel suo cuore.
Il suo legame con la Liguria è stretto e non si è mai interrotto, nonostante la sua carriera l’abbia portato un po’ ovunque in Italia e anche all’estero: Francia, Germania, Grecia, U.S.A., Finlandia.
Tra la fine del 2013 e l’inizio del 2014 ha donato a Genova, città capoluogo della sua regione d’adozione, 40 opere, realizzate nello studio di Sestri Levante e nella casa di Borzonasca, nelle quali documenta il suo percorso pittorico tra la metà degli anni Sessanta e la contemporaneità.
Lo ha fatto destinandole a due musei aperti al pubblico, alla Galleria d’Arte Moderna – che quest'anno celebra i cent'anni dal primo atto che ne sanciva l'esistenza nel 1914, e i dieci anni dalla riapertura completamente rinnovata nel 2004 - e al Museo dell’Accademia Ligustica di Belle Arti.
Le due mostre, in corso contemporaneamente nei due musei, sono state prorogate.
Sarà quindi possibile visitarle fino al 28 settembre alla GAM e al 13 settembre all’Accademia Ligustica di Belle Arti.
Un’artista animato da entusiasmo civico. Scosso nel profondo dalla tragica eredità culturale di regimi e di conflitti, nelle sue opere si ritrovano temi di denuncia e di impegno sociale e civile.
In continuo rapporto dialettico con letterati, drammaturghi e poeti del suo tempo, Grande è portato a guardarsi costantemente dentro, a lasciarsi coinvolgere dalle inquietudini dell’esistenzialismo. Presta attenzione alla contestazione giovanile e all’avvilimento di una società coinvolta, a dispetto del progresso, in assurde e interminabili guerre come quella asiatica, ben sintetizzata dal dipinto Vietnam del 1964.
Al medesimo impegno deve essere ricondotta la scelta di dipingere gli indiani del Nordamerica: un tema frequentato dal cinema americano del Dopoguerra, rivisitato in Italia negli anni Sessanta da Sergio Leone, rappresentato anche in tanti fumetti. Un genere che vedeva contrapposti, senza alcuna esitazione, buoni e cattivi, coraggio e lealtà da una parte e barbarie e crudeltà dall’altra.
I suoi indiani sono però lontanissimi dalle immagini stereotipate veicolate da questi media . Il tema dei Pellerossa assume una valenza diversa, e costituisce l’oggetto di due personali interamente dedicate agli “Indiani d’America” a Lavagna, nel 1984, e nel 1992 a Genova, quasi contraltare alle celebrazioni ufficiali del quinto centenario della “scoperta” dell’America, evento che aveva segnato l’avvio del genocidio delle tribù pellerossa . E non a caso, ancora, chiamato a partecipare alla mostra - Crêuze de mâ, crêuze d’amô, Dedicato ad un amico. Omaggio a Fabrizio De André- per ricordare il cantautore genovese nel 2000, tra i tanti e variegati temi della poetica di De André, Grande scelse di presentare la tela Indiano del Sand Creek. Ritratto severo e dignitoso di uno sconfitto, imperturbabile e altero nel suo silenzio, ispirato alla celebre ballata incisa dal cantautore in un album del 1981, che aveva in copertina proprio l’immagine di un nativo americano a cavallo, opera dell’artista statunitense Frederic Remington.
Non si tratta, tuttavia, di un omaggio “risarcitorio”: Hollywood lo avrebbe fatto con pellicole passate alla storia del cinema quali Piccolo grande uomo e Soldato blu del 1970, o il più tardo Balla coi lupi del 1990.
Gli indiani di Luigi Grande, scampati al genocidio, sono l’immagine dei “sopravvissuti” del mondo, eroi loro malgrado.
Il catalogo delle due mostre, edito da Sagep, è curato da Maria Flora Giubilei e da Giulio Sommariva. I saggi sono firmati dai due curatori e da Maria Teresa Orengo, che ha rievocato l'intensa amicizia dell'artista con il padre, il noto poeta e drammaturgo Vico Faggi.
Il suo legame con la Liguria è stretto e non si è mai interrotto, nonostante la sua carriera l’abbia portato un po’ ovunque in Italia e anche all’estero: Francia, Germania, Grecia, U.S.A., Finlandia.
Tra la fine del 2013 e l’inizio del 2014 ha donato a Genova, città capoluogo della sua regione d’adozione, 40 opere, realizzate nello studio di Sestri Levante e nella casa di Borzonasca, nelle quali documenta il suo percorso pittorico tra la metà degli anni Sessanta e la contemporaneità.
Lo ha fatto destinandole a due musei aperti al pubblico, alla Galleria d’Arte Moderna – che quest'anno celebra i cent'anni dal primo atto che ne sanciva l'esistenza nel 1914, e i dieci anni dalla riapertura completamente rinnovata nel 2004 - e al Museo dell’Accademia Ligustica di Belle Arti.
Le due mostre, in corso contemporaneamente nei due musei, sono state prorogate.
Sarà quindi possibile visitarle fino al 28 settembre alla GAM e al 13 settembre all’Accademia Ligustica di Belle Arti.
Un’artista animato da entusiasmo civico. Scosso nel profondo dalla tragica eredità culturale di regimi e di conflitti, nelle sue opere si ritrovano temi di denuncia e di impegno sociale e civile.
In continuo rapporto dialettico con letterati, drammaturghi e poeti del suo tempo, Grande è portato a guardarsi costantemente dentro, a lasciarsi coinvolgere dalle inquietudini dell’esistenzialismo. Presta attenzione alla contestazione giovanile e all’avvilimento di una società coinvolta, a dispetto del progresso, in assurde e interminabili guerre come quella asiatica, ben sintetizzata dal dipinto Vietnam del 1964.
Al medesimo impegno deve essere ricondotta la scelta di dipingere gli indiani del Nordamerica: un tema frequentato dal cinema americano del Dopoguerra, rivisitato in Italia negli anni Sessanta da Sergio Leone, rappresentato anche in tanti fumetti. Un genere che vedeva contrapposti, senza alcuna esitazione, buoni e cattivi, coraggio e lealtà da una parte e barbarie e crudeltà dall’altra.
I suoi indiani sono però lontanissimi dalle immagini stereotipate veicolate da questi media . Il tema dei Pellerossa assume una valenza diversa, e costituisce l’oggetto di due personali interamente dedicate agli “Indiani d’America” a Lavagna, nel 1984, e nel 1992 a Genova, quasi contraltare alle celebrazioni ufficiali del quinto centenario della “scoperta” dell’America, evento che aveva segnato l’avvio del genocidio delle tribù pellerossa . E non a caso, ancora, chiamato a partecipare alla mostra - Crêuze de mâ, crêuze d’amô, Dedicato ad un amico. Omaggio a Fabrizio De André- per ricordare il cantautore genovese nel 2000, tra i tanti e variegati temi della poetica di De André, Grande scelse di presentare la tela Indiano del Sand Creek. Ritratto severo e dignitoso di uno sconfitto, imperturbabile e altero nel suo silenzio, ispirato alla celebre ballata incisa dal cantautore in un album del 1981, che aveva in copertina proprio l’immagine di un nativo americano a cavallo, opera dell’artista statunitense Frederic Remington.
Non si tratta, tuttavia, di un omaggio “risarcitorio”: Hollywood lo avrebbe fatto con pellicole passate alla storia del cinema quali Piccolo grande uomo e Soldato blu del 1970, o il più tardo Balla coi lupi del 1990.
Gli indiani di Luigi Grande, scampati al genocidio, sono l’immagine dei “sopravvissuti” del mondo, eroi loro malgrado.
Il catalogo delle due mostre, edito da Sagep, è curato da Maria Flora Giubilei e da Giulio Sommariva. I saggi sono firmati dai due curatori e da Maria Teresa Orengo, che ha rievocato l'intensa amicizia dell'artista con il padre, il noto poeta e drammaturgo Vico Faggi.