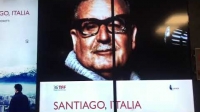Mercoledì 12 febbraio si è svolto a Palazzo Tursi il convegno “Liana Millu 1914-2005” in occasione del centenario della nascita dell’autrice de “Il fumo di Birkenau”. L’evento è stato organizzato dall’Istituto ligure per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea (ILSREC), dal Dipartimento di Italianistica, Romanistica, Antichistica, Arti e Spettacolo (DIRAAS) dell’Università di Genova, dal Comune di Genova, con l’adesione della Comunità Ebraica di Genova.
Ad aprire il convegno i saluti dell’assessore alla scuola Pino Boero , del prorettore dell’Università di Genova Maurizio Martelli e del presidente ILSREC Giacomo Ronzitti. Nei diversi interventi che si sono alternati è stata tratteggiata la figura di Liana Millu: la sua carriera di insegnante, giornalista e scrittrice, la sua breve militanza nella resistenza, la deportazione, il ritorno dal campo di concentramento, la sua attività di testimonianza concretizzatasi nel suo libro “Il fumo di Birkenau”.
«Sono il n. A 5384 di Auschwitz-Birkenau» queste le parole con le quali iniziava le sue testimonianze nelle scuole e con i giovani, ai quali parlava con «linguaggio semplice, diretto, di una grande tragedia» ha detto il sindaco Marco Doria nel portare il saluto al convegno, alla ripresa pomeridiana dei lavori.
Il sindaco ha ricordato come Liana Millu sapesse rendere "straordinariamente efficace" la propria testimonianza di perseguitata e deportata. Di quel suo modo di testimoniare attraverso il racconto, Doria ha individuato tre modalità. La prima era mettere in evidenza l'assoluta casualità con cui veniva decisa la morte o la sopravvivenza: bastavano pochi passi per essere salvi o finire nella camera a gas, in "una situazione di assoluto arbitrio, alla quale si era assoggettati". La seconda testimonianza nel racconto riguardava la disumanizzazione della persona. Millu raccontava ai ragazzi - ha osservato il sindaco - il taglio dei capelli, il tatuaggio del numero sul corpo per cancellare nome e cognome e togliere ai prigionieri la loro identità. Infine, terzo elemento, il richiamo attuale a sentirsi coinvolti in avvenimenti lontani. Citando Bertold Brecht, la scrittrice ammoniva che non è possibile rimanere indifferenti quando si mettono in moto certi meccanismi di persecuzione e di razzismo: anche se all'inizio ne siamo esclusi, alla fine anche noi saremo travolti.
In occasione del convegno è stato donato al Comune di Genova, da Piero Stefani, il Tagebuch, il diario manoscritto di Liana Millu, redatto nei mesi successivi alla liberazione dal lager, che sarà conservato presso la Biblioteca Berio.
Dopo gli interventi di Guido Levi(Università di Genova), Paolo Battiflora (Ilsrec), Marta Baiardi (Università di Basilea), Fernanda Contri (già Giudice della Corte Costituzionale), le testimonianze di Gilberto Salmoni (Aned Genova) e Miryam Kraus (Comunità Ebraica di Genova), l’attrice Ottavia Piccolo ha letto brani di Liana Millu.
La sessione del mattino è stata presieduta da Stefano Verdino, dell’Università di Genova, sono intervenuti: Piero Stefani (Università di Ferrara), Ombretta Freschi (Ilsrec), Anna Szwarc Zajac (Università “Adam Mickiewicz” di Poznan) e Daniel Vogelmann (Casa Editrice Giuntina). Elisabetta Tonizzi (Università di Genova) ha presieduto la parte pomeridiana del convegno
Liana Millu (Pisa 21/12/1914 - Genova 6/2/2005), di famiglia ebrea, intraprese la carriera di insegnante, coltivando al tempo stesso l’ambizione di fare la giornalista, obiettivo concretizzatosi nel 1937 quando iniziò a collaborare con Il Telegrafo, giornale livornese diretto da Giovanni Ansaldo. Espulsa dalla scuola e dal mondo giornalistico in virtù delle leggi razziali del 1938, dopo l’8 settembre, aderì alla Resistenza, entrando nell’organizzazione Otto. Arrestata a Venezia nel marzo 1944, trasferita nel campo di Fossoli, in maggio venne deportata ad Auschwitz, poi a Ravensbrück, ed infine a Malkow, presso Stettino, sottocampo ove venne liberata il 30 aprile 1945. Stabilitasi a Genova e ripresa l’attività di maestra elementare, nel dopoguerra ha collaborato a diverse riviste e quotidiani e ha svolto un’intensa attività di testimonianza. Il suo libro “Il fumo di Birkenau” (1947), tra le più intense opere sulla deportazione femminile, è stato tradotto nelle principali lingue.
Nel 1994 è stata insignita del Grifo d’oro, la massima onorificenza del Comune di Genova.
Ad aprire il convegno i saluti dell’assessore alla scuola Pino Boero , del prorettore dell’Università di Genova Maurizio Martelli e del presidente ILSREC Giacomo Ronzitti. Nei diversi interventi che si sono alternati è stata tratteggiata la figura di Liana Millu: la sua carriera di insegnante, giornalista e scrittrice, la sua breve militanza nella resistenza, la deportazione, il ritorno dal campo di concentramento, la sua attività di testimonianza concretizzatasi nel suo libro “Il fumo di Birkenau”.
«Sono il n. A 5384 di Auschwitz-Birkenau» queste le parole con le quali iniziava le sue testimonianze nelle scuole e con i giovani, ai quali parlava con «linguaggio semplice, diretto, di una grande tragedia» ha detto il sindaco Marco Doria nel portare il saluto al convegno, alla ripresa pomeridiana dei lavori.
Il sindaco ha ricordato come Liana Millu sapesse rendere "straordinariamente efficace" la propria testimonianza di perseguitata e deportata. Di quel suo modo di testimoniare attraverso il racconto, Doria ha individuato tre modalità. La prima era mettere in evidenza l'assoluta casualità con cui veniva decisa la morte o la sopravvivenza: bastavano pochi passi per essere salvi o finire nella camera a gas, in "una situazione di assoluto arbitrio, alla quale si era assoggettati". La seconda testimonianza nel racconto riguardava la disumanizzazione della persona. Millu raccontava ai ragazzi - ha osservato il sindaco - il taglio dei capelli, il tatuaggio del numero sul corpo per cancellare nome e cognome e togliere ai prigionieri la loro identità. Infine, terzo elemento, il richiamo attuale a sentirsi coinvolti in avvenimenti lontani. Citando Bertold Brecht, la scrittrice ammoniva che non è possibile rimanere indifferenti quando si mettono in moto certi meccanismi di persecuzione e di razzismo: anche se all'inizio ne siamo esclusi, alla fine anche noi saremo travolti.
In occasione del convegno è stato donato al Comune di Genova, da Piero Stefani, il Tagebuch, il diario manoscritto di Liana Millu, redatto nei mesi successivi alla liberazione dal lager, che sarà conservato presso la Biblioteca Berio.
Dopo gli interventi di Guido Levi(Università di Genova), Paolo Battiflora (Ilsrec), Marta Baiardi (Università di Basilea), Fernanda Contri (già Giudice della Corte Costituzionale), le testimonianze di Gilberto Salmoni (Aned Genova) e Miryam Kraus (Comunità Ebraica di Genova), l’attrice Ottavia Piccolo ha letto brani di Liana Millu.
La sessione del mattino è stata presieduta da Stefano Verdino, dell’Università di Genova, sono intervenuti: Piero Stefani (Università di Ferrara), Ombretta Freschi (Ilsrec), Anna Szwarc Zajac (Università “Adam Mickiewicz” di Poznan) e Daniel Vogelmann (Casa Editrice Giuntina). Elisabetta Tonizzi (Università di Genova) ha presieduto la parte pomeridiana del convegno
Liana Millu (Pisa 21/12/1914 - Genova 6/2/2005), di famiglia ebrea, intraprese la carriera di insegnante, coltivando al tempo stesso l’ambizione di fare la giornalista, obiettivo concretizzatosi nel 1937 quando iniziò a collaborare con Il Telegrafo, giornale livornese diretto da Giovanni Ansaldo. Espulsa dalla scuola e dal mondo giornalistico in virtù delle leggi razziali del 1938, dopo l’8 settembre, aderì alla Resistenza, entrando nell’organizzazione Otto. Arrestata a Venezia nel marzo 1944, trasferita nel campo di Fossoli, in maggio venne deportata ad Auschwitz, poi a Ravensbrück, ed infine a Malkow, presso Stettino, sottocampo ove venne liberata il 30 aprile 1945. Stabilitasi a Genova e ripresa l’attività di maestra elementare, nel dopoguerra ha collaborato a diverse riviste e quotidiani e ha svolto un’intensa attività di testimonianza. Il suo libro “Il fumo di Birkenau” (1947), tra le più intense opere sulla deportazione femminile, è stato tradotto nelle principali lingue.
Nel 1994 è stata insignita del Grifo d’oro, la massima onorificenza del Comune di Genova.